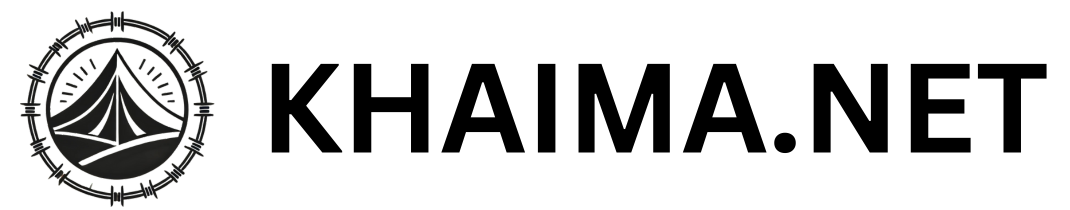Un popolo resistente: dal passato coloniale al presente di occupazione
Il Sahara Occidentale resta l’ultima colonia d’Africa, ma il popolo saharawi non ha mai smesso di credere nel ritorno alla propria terra.
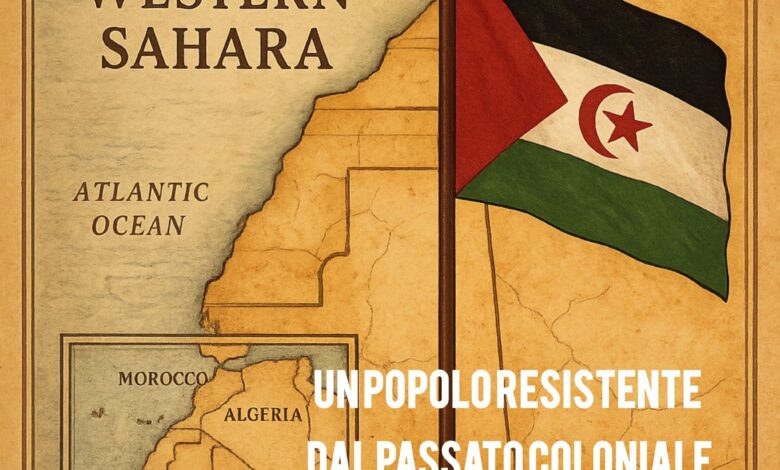
Nel silenzio profondo del deserto, dove il vento racconta storie millenarie attraverso le dune di sabbia dorata, nasce la storia del popolo saharawi. È qui, tra le vastità infinite dell’Hammada e le coste battute dall’Atlantico, che le tribù berbere Sanhaja e Zenata incontrarono, nel corso dei secoli, le popolazioni arabe Ma’qil provenienti dallo Yemen. Questo incontro, avvenuto tra l’XI e il XIII secolo, diede vita a un popolo unico: i saharawi, letteralmente “gli abitanti del deserto”, portatori di una cultura nomade che avrebbe resistito a secoli di dominazioni e oppressioni.
La società saharawi che si formò era organizzata intorno alla jaima, la tenda tradizionale dove si custodivano i segreti della sopravvivenza nel deserto e dove le donne tramandavano, di madre in figlia, la poesia in hassaniya, quella lingua melodiosa che conserva l’anima di un popolo. Non erano semplicemente nomadi: possedevano una struttura politica sofisticata chiamata Dawlat Albadia (Il paese del nomadismo), con un’amministrazione nota come Eid Arbain (La mano dei Quaranta), costituita nel 1556. I loro confini, riconosciuti e rispettati, erano chiamati Jat Al-Jaof (La linea del timore), e la loro cultura si estendeva dalle coste atlantiche fino ai confini del Sudan.
Ma quella che per gli stranieri appariva come una terra vuota – terra nullius – era in realtà la patria ancestrale di migliaia di anni di civiltà nomade. Come racconta la tradizione orale saharawi, tramandata attraverso generazioni di imusnawen (custodi della conoscenza), ogni pietra del deserto aveva un nome, ogni pozzo una storia, ogni passo delle carovane un significato. Era un mondo dove la poesia non era ornamento ma saggezza, dove ogni verso conteneva le chiavi per sopravvivere alle tempeste di sabbia e trovare l’acqua nascosta sotto le dune.
Secondo gli archivi francesi del Service historique de la Défense, i rapporti diplomatici tra Francia e Spagna nel periodo 1931-1936 testimoniano come le potenze europee considerassero questo territorio come “un insieme di possessioni sulla costa occidentale d’Africa”, ignorando completamente l’esistenza di strutture politiche preesistenti. Tuttavia, i documenti d’archivio rivelano che i saharawi possedevano già – come si è detto – un sofisticato sistema di governo tribale basato sul Consiglio dei Quaranta, che gestiva le questioni territoriali, commerciali e di giustizia molto prima dell’arrivo degli europei.
L’arrivo dei conquistatori, la spartizione dell’Africa e l’inizio dell’incubo coloniale
Il destino del popolo saharawi cambiò radicalmente nel 1884, quando le potenze europee si riunirono a Berlino per spartirsi l’Africa come fosse una torta. In quella sala dove si decisero i destini di milioni di africani senza consultarli, la Spagna ottenne la sua fetta: il territorio compreso tra Capo Bojador e Capo Blanco. La Conferenza di Berlino del 1885 sancì così l’inizio di un’era di sofferenza per i saharawi, che videro la loro terra ancestrale trasformata in “Sahara Spagnolo”.
Ma i colonizzatori non immaginavano la ferocia della resistenza che avrebbero incontrato. Come documenta lo storico ungherese János Besenyő nella sua ricerca approfondita sul Sahara Occidentale sotto l’impero spagnolo, fin dal marzo 1884, i guerrieri saharawi attaccarono la prima guarnigione spagnola a Wadi al-Dhahab (oggi Dakhla), conquistando la base coloniale e catturando tutto ciò che conteneva. Non fu un episodio isolato: il 24 marzo 1887, quando i colonialisti ricostruirono la guarnigione, i saharawi la attaccarono nuovamente, dimostrando che non avrebbero mai accettato passivamente l’occupazione straniera.
Gli archivi spagnoli del periodo rivelano che, fin dall’inizio della penetrazione europea, i saharawi organizzarono questa resistenza sistematica. La documentazione dell’Università di Murcia, nella sua analisi della colonizzazione tardiva spagnola (1885-1975), “España en el Sáhara Occidental”, riporta che passarono 48 anni prima che la Spagna riuscisse ad iniziare l’occupazione effettiva dell’insieme del territorio sahariano. Questo lungo periodo di resistenza testimonia la determinazione e l’organizzazione del popolo saharawi.
La resistenza saharawi tra il 1908 e il 1934 divenne leggendaria. Secondo i rapporti militari francesi conservati negli archivi nazionali, dal marzo al settembre 1908, si registrarono 125 battaglie che costarono la vita a 200 francesi, tra cui tre ufficiali e cinque sottufficiali. Il 10 gennaio 1913, in quello che rimane uno degli episodi più gloriosi della resistenza saharawi, i guerrieri attaccarono la guarnigione francese ad al-Bayrat, uccidendo 55 francesi e catturando 105 fucili, ventimila casse di munizioni e cinquecento cammelli, al costo di 14 martiri saharawi.
Il colonialismo europeo rispose con una violenza inaudita. L’Operazione Écosseflon del 1958 rappresentò uno dei momenti più bui: un bombardamento aereo massiccio condotto congiuntamente da Francia e Spagna con 9.000 soldati spagnoli e 5.000 francesi, che uccise migliaia di cammelli saharawi – quell’anno fu chiamato “am al-hajm” (l’anno dell’attacco) – e rese i pascoli inutilizzabili, costringendo molti saharawi a trasferirsi nelle città come parte di una politica deliberata di controllo della popolazione.
Vivere sotto il giogo: la trasformazione forzata di una società nomade
La vita sotto il colonialismo spagnolo divenne una continua negoziazione tra il sopravvivere e il tentativo di preservare la dignità. Dal 1958, nell’ambito del cosiddetto “secondo colonialismo”, la pressione sui modi di vita tradizionali saharawi si intensificò drammaticamente. Come documenta la ricerca franco-spagnola sui “últimas revelaciones de los archivos franceses”, gli spagnoli implementarono politiche di urbanizzazione forzata attraverso la strategia della “terra bruciata”, che mirava a costringere gli abitanti del badiya (deserto) a stabilirsi nelle città per controllarli meglio.
Nonostante l’immagine “paternalistica” che la Spagna cercava di proiettare, il sistema coloniale manteneva un controllo rigoroso: proibiva manifestazioni pubbliche, partiti politici e discorsi anti-governativi. I colonialisti reclutarono informatori dalle comunità saharawi nell’esercito spagnolo, creando le cosiddette “forze beduine” (Troopas de Nomadas), mentre molti giovani saharawi furono costretti a lavorare nelle miniere di fosfati di Bu Craa, una delle più grandi riserve di fosfati al mondo, che la Spagna sfruttava esclusivamente per i propri interessi economici.
Gli sviluppi degli anni ’50 e ’60 portarono a trasformazioni sociali profonde e traumatiche. Le tradizionali comunità nomadi saharawi si trasformarono in comunità periferiche dipendenti da lavori salariati, sussidi e borse di studio. I colonialisti utilizzarono abilmente le strutture tribali esistenti, creando un tipo specifico di relazioni coloniali che differiva da quelle imposte nei territori vicini, ma che non era meno oppressivo.
Secondo i documenti del Servizio Storico della Difesa francese, l’organizzazione militare dei territori sahariani spagnoli prevedeva un sistema di controllo capillare attraverso presidi militari distribuiti strategicamente nel territorio. La documentazione rivela come la Spagna mantenesse presenze militari significative: nel 1930 il personale dell’unità nomade comprendeva 30 europei (inclusi 6 ufficiali) e 198 saharawi, che disponevano di 62 cavalli e 183 cammelli.
Tuttavia, nelle khaimas (tende) e nelle case, la resistenza culturale continuava. Le madri saharawi continuavano a insegnare ai loro figli la poesia in hassaniya, le tradizioni ancestrali, la storia del loro popolo. Come ricorda il poeta Bahia Mahmud Awah: “Mia madre era una studiosa versata nella letteratura tradizionale saharawi in hassaniya”. Era attraverso queste donne, custodi della memoria collettiva, che si preservava ciò che il colonialismo cercava disperatamente di distruggere: l’anima di un popolo che rifiutava di morire.
Il Risveglio della Coscienza: Dall’Intifada di Zemla alla Nascita della Resistenza Armata
Il 17 giugno 1970 segna una data che brucia nella memoria di ogni saharawi come il momento in cui la resistenza pacifica lasciò spazio alla determinazione rivoluzionaria. Quel giorno, nel quartiere di Zemla ad El Aaiún, Muhammad Sidi Ibrahim Basiri guidò una manifestazione che avrebbe cambiato per sempre il corso della storia saharawi. Basiri, nato nel 1942, era un giornalista e insegnante del Corano che aveva studiato in Egitto e Siria, dove aveva assorbito gli ideali nasseriani e dei movimenti di liberazione arabi.
Secondo la documentazione araba sulla resistenza saharawi, la Munazzama al-Tala’iyya li-Tahrir al-Saqiya al-Hamra (Organizzazione d’Avanguardia per la Liberazione della Saguia el-Hamra), conosciuta anche come al-Haraka al-Tala’iyya li-Tahrir al-Saqiya al-Hamra wa Wadi al-Dhahab (Movimento d’Avanguardia per la Liberazione della Saguia el-Hamra e Wadi al-Dhahab), fu fondata segretamente da Basiri alla fine del 1969. L’organizzazione si pose obiettivi chiari: la liberazione completa del Sahara Occidentale dall’occupazione spagnola, l’istituzione di uno stato indipendente e il rifiuto dell’integrazione con qualsiasi altra entità.
Quando i manifestanti si radunarono per presentare un memorandum al governatore generale spagnolo José María Pérez de Lema y Tejero, chiedendo l’indipendenza e un trattamento equo per i saharawi, non sapevano di star scrivendo una pagina eroica della loro storia. I manifestanti alzarono slogan che rifiutavano l’integrazione, chiedevano l’insegnamento della lingua araba e l’uscita della Spagna, condannavano la deportazione dei giovani saharawi e contestavano la rappresentatività della Jemaa (assemblea tribale controllata dagli spagnoli).
La risposta spagnola fu brutale: quando tentò di arrestare i leader del movimento e i manifestanti risposero lanciando pietre, le autorità chiamarono la Legione Straniera, che aprì il fuoco sui dimostranti inermi. La documentazione araba riporta che “fu accolta questa manifestazione pacifica con la forza delle armi da parte del colonialismo spagnolo, dove furono uccisi e feriti un gran numero di saharawi e centinaia furono gettati nelle prigioni”. Tra 11 e 12 persone persero la vita, molte altre rimasero ferite, e centinaia furono arrestate.
Ma il simbolo più potente di quella giornata fu la scomparsa di Basiri stesso, che venne arrestato e non fu mai più visto. Divenne così il primo “desaparecido” saharawi, il primo martire di una causa che da quel momento non avrebbe più conosciuto compromessi. Come gridano oggi i saharawi nei loro campi profughi: “Bi-l-bunduqiyya nanal al-hurriyya” (Con il fucile otteniamo la libertà).
Gli eventi di Zemla portarono al crollo del movimento di liberazione di Basiri, ma come una fenice che rinasce dalle ceneri, spinsero il movimento nazionale saharawi ad abbracciare la lotta armata. Secondo la documentazione araba, la risposta spagnola contro l’Organizzazione d’Avanguardia portò a “riflettere su un nuovo metodo per costruire un’organizzazione che inquadri le masse saharawi, unisca le loro energie e adotti le loro rivendicazioni legittime nella lotta contro il colonizzatore spagnolo e la sua liquidazione dal Sahara Occidentale”.
Il 10 maggio 1973, ad Ain Ben Tili in Mauritania, nacque il Frente Popular para la Liberación de Saguía el-Hamra y Río de Oro – il Polisario. La fondazione della Polisario fu il risultato di un processo preparatorio iniziato nel febbraio 1973, quando furono formati vari comitati segreti che iniziarono a stabilire contatti con la popolazione all’interno del Sahara Occidentale e nei luoghi di presenza della comunità saharawi per sensibilizzarli e raccogliere opinioni e suggerimenti. Dieci giorni dopo la fondazione, il 20 maggio 1973, il primo attacco militare contro un posto di polizia a El Janga annunciò al mondo che era iniziata una guerra di liberazione che avrebbe segnato i successivi decenni.
Il Grande Tradimento: Gli Accordi di Madrid e l’Abbandono dell’Occidente
Il 1975 avrebbe dovuto essere l’anno della liberazione per i saharawi. La Corte Internazionale di Giustizia aveva parlato chiaro il 16 ottobre: “I materiali e le informazioni presentati non stabiliscono alcun legame di sovranità territoriale tra il territorio del Sahara Occidentale e il Regno del Marocco o l’entità mauritana”. Una missione investigativa delle Nazioni Unite aveva già pubblicato conclusioni inequivocabili, dimostrando che la popolazione saharawi era “overwhelmingly” (schiacciariamente) a favore dell’indipendenza.
Come documenta il ricercatore algerino Dr. Mohamed Doumir nei suoi interventi presso il Comitato Speciale per la Decolonizzazione delle Nazioni Unite, i documenti storici ufficiali dimostrano che il Sahara Occidentale e il Regno del Marocco sono due territori distinti. Doumir ha presentato trattati firmati dai re di Marrakech con gli Stati Uniti nel 1787 e 1836, con la Francia nel 1763 e 1868, così come con Gran Bretagna, Italia, Spagna e altri paesi, in cui “dal 1767, i re del Marocco hanno scritto nei loro trattati che questo territorio (il Sahara Occidentale) è libero e non sotto la tutela marocchina”.
Ma il 14 novembre 1975 si consumò uno dei tradimenti più clamorosi della storia della decolonizzazione: la firma degli Accordi di Madrid. La Spagna, pressata dalla Marcia Verde del Marocco – quando circa 350.000 marocchini accompagnati da soldati armati entrarono nel territorio il 6 novembre 1975 – decise di abbandonare le sue responsabilità coloniali senza consultare il popolo saharawi. Come riporta la documentazione francese sul Sahara Occidentale, l’accordo tripartito di Madrid rappresentò “la cessione del Sahara al Marocco e alla Mauritania”, ignorando completamente la volontà del popolo che lo abitava.
Il 26 febbraio 1976, l’ultimo soldato spagnolo lasciò il territorio. Il giorno successivo, per colmare il vuoto istituzionale lasciato dalla partenza dell’esercito spagnolo, i quadri del movimento nazionalista saharawi proclamarono la Repubblica Araba saharawi Democratica (RASD). La prima costituzione, adottata alla fine di agosto 1976, rifletteva la rivoluzione sociale guidata dal Polisario: non conteneva più tracce di affiliazioni tribali, segnando il passaggio da una società basata sui lignaggi a una nazione moderna.
Ma la proclamazione dell’indipendenza dovette essere pagata a caro prezzo. Quello che seguì fu una delle guerre più brutali dell’Africa moderna, quando il Marocco e la Mauritania occuparono militarmente il territorio, trovando i posti abbandonati dagli spagnoli già occupati dai guerriglieri del Polisario. La resistenza saharawi fu accolta con una repressione di straordinaria durezza da parte del Marocco, che costrinse circa 40.000 persone – principalmente bambini, donne e anziani – a fuggire verso la frontiera con l’Algeria tra dicembre 1975 e gennaio 1976.
Secondo i documenti delle Nazioni Unite, il Consiglio di Sicurezza condannò l’invasione marocchina con la risoluzione 380/1975, esortando “il Marocco a ritirare immediatamente dal territorio del Sahara Occidentale tutti i partecipanti alla marcia”. Durante questo periodo, come documentano le testimonianze raccolte dai campi profughi, “la popolazione saharawi che fuggiva dal territorio in cerca di sicurezza fu bombardata con napalm e fosforo bianco dagli aerei marocchini”.
L’Esilio e la Guerra: Quando il Deserto Divenne Campo di Battaglia
Per spezzare la volontà di resistenza dei saharawi, il Marocco scatenò una guerra totale che non risparmiò nemmeno i civili. I campi profughi furono bombardati ricorrentemente con napalm, mentre le forze marocchine cercavano di annientare ogni forma di resistenza. Ma i saharawi, figli del deserto, trasformarono la loro conoscenza ancestrale del territorio in un’arma formidabile contro gli occupanti.
Il Polisario riuscì a costringere la Mauritania a rinunciare alla sua rivendicazione sul Sahara Occidentale nel 1979 e continuò la sua campagna militare contro il Marocco fino al cessate il fuoco del 1991. Durante gli anni ’80, per contenere i guerriglieri saharawi, il Marocco costruì uno dei muri più lunghi del mondo: il berm, una barriera di sabbia, pietre e mine antiuomo lunga oltre 2.000 chilometri che divise il territorio e il popolo saharawi.
Secondo la documentazione francese sul conflitto, il muro “di vergogna”, che separa il Sahara Occidentale in due, è composto da sei muri per una lunghezza totale di oltre 2.700 chilometri. I muri hanno permesso di fermare le incursioni del Fronte Polisario all’interno del territorio sahariano. Questo muro, conosciuto dalla popolazione saharawi con il nome di Al Yidar, è il più grande muro militare del mondo.
Il muro divenne il simbolo concreto della divisione: da una parte, i saharawi sotto l’occupazione marocchina; dall’altra, quelli nei campi profughi nel sud dell’Algeria. Ma anche nei campi di Tindouf, nell’Hammada più arida e inospitale, i saharawi dimostrarono una capacità straordinaria di organizzazione e resistenza. Costruirono scuole, ospedali, istituzioni democratiche, mantenendo viva la speranza del ritorno nella loro terra ancestrale.
Le Promesse Tradite: Dal Cessate il Fuoco alle Nuove Intifade (1991-2020)
Il 6 settembre 1991 entrò in vigore un cessate il fuoco tra il Polisario e il Marocco, monitorato dalla MINURSO (Missione delle Nazioni Unite per il Referendum nel Sahara Occidentale), con la promessa di un referendum sull’indipendenza entro l’anno successivo. Ma quella promessa si rivelò l’ennesima illusione per i saharawi. Il referendum si arenò per i continui ostacoli posti dal Marocco, che considerava il Sahara Occidentale parte integrante del suo territorio.
L’anno 2005 segnò l’inizio di una nuova fase nella lotta saharawi, caratterizzata da un’escalation di resistenza civile che molti storici considerano come l’anticipazione delle Primavere Arabe. Il 21 maggio 2005, quando le forze marocchine dispersero violentemente i parenti di un prigioniero saharawi, si accese quella che venne chiamata la “Seconda Intifada Sahrawi” o “Intifada dell’Indipendenza”. Le manifestazioni si estesero rapidamente oltre El Aaiún, mentre gli studenti saharawi nelle università marocchine organizzavano dimostrazioni di solidarietà e scioperi della fame.
Il 30 ottobre 2005, Hamdi Lembarki morì dopo quella che le organizzazioni per i diritti umani confermarono essere brutalità poliziesche, diventando il primo martire di questa nuova fase di lotta. Il 14 dicembre 2005, 14 attivisti per l’indipendenza, inclusa la famosa Aminatou Haidar, furono condannati a pene tra i sei mesi e i tre anni di prigione.
Il culmine arrivò con il campo di protesta di Gdeim Izik, eretto il 9 ottobre 2010 a 12 chilometri da El Aaiún. Quello che iniziò come alcune centinaia di khaimas tradizionali divenne rapidamente la più grande manifestazione mai organizzata dal popolo saharawi: entro novembre, il campo ospitava oltre 20.000 persone. Era il “campo della dignità”, una dichiarazione vivente che l’occupazione rendeva inabitabili le loro città.
L’8 novembre 2010, alle prime ore del mattino, le forze di sicurezza marocchine smantellarono violentemente il campo utilizzando elicotteri e cannoni ad acqua. Secondo il Polisario, 36 saharawi furono uccisi, 723 feriti e 163 arrestati. Come disse Ghalia Djimi, vicedirettore dell’Associazione per le vittime di violazione dei diritti civili: “la resistenza era pacifica, nonostante l’aggressione della polizia e della gendarmeria”.
Il Ritorno della Guerra: Dalla Violazione del Cessate il Fuoco al Conflitto Contemporaneo (2020-2025)
La svolta definitiva arrivò il 13 novembre 2020, quando il Marocco violò il cessate il fuoco che resisteva dal 1991. Le forze armate marocchine penetrarono nella zona cuscinetto di Guerguerat per sgomberare i manifestanti saharawi che bloccavano pacificamente il passaggio commerciale dal 21 ottobre. Il presidente saharawi Brahim Ghali dichiarò immediatamente la fine dell’impegno del cessate il fuoco. Dopo 29 anni di tregua, la guerra era tornata.
Quello che seguì fu un conflitto a bassa intensità lungo i 2.700 chilometri del muro di sabbia. Il Polisario ha rivendicato almeno 1.600 attacchi nell’ultimo anno, mentre il Marocco ha risposto utilizzando droni acquistati dalla Turchia e, secondo alcune fonti, da Israele. Nel 2021, Addah Al-Bendir, capo della gendarmeria del Polisario, fu ucciso in un attacco con droni, mentre a novembre 2021, tre civili algerini persero la vita in un altro attacco vicino a Bir Lahlou.
Il sostegno dell’Iran al Polisario, rivelato nel 2024, ha aggiunto una nuova dimensione geopolitica al conflitto. Secondo il Washington Post, l’Iran ha addestrato combattenti del Polisario attraverso Hezbollah, con centinaia di militanti che hanno combattuto in Siria per conto del regime di Assad. Questa evoluzione ha trasformato il conflitto sahrawi da questione regionale a tassello degli equilibri geopolitici globali.
Le storie di Aminatou Haidar e Sultana Khaya incarnano la brutalità sistematica che i saharawi continuano a subire. Aminatou, sopravvissuta alla Carcèl Negra dove fu tenuta bendata per quattro anni e torturata, nel 2009 fu espulsa dal Marocco per aver scritto “Sahara Occidentale” come luogo di residenza. Sultana Khaya, presidente della Lega per la Difesa dei Diritti Umani, è sottoposta ad arresti domiciliari de facto dal novembre 2020, con le forze di sicurezza marocchine che mantengono “una presenza pesante quasi costante” fuori dalla sua casa. Nel novembre 2024, secondo l’Organo saharawi Contro l’Occupazione Marocchina, le forze di polizia marocchine hanno saccheggiato la sua casa e commesso violenze sessuali contro lei e sua sorella.
Come sottolinea il rappresentante del Polisario alle Nazioni Unite, Sidi Mohamed Omar, il riconoscimento francese del piano di autonomia marocchino “non è nuovo nella sua essenza e tutto quello che è successo è che la Francia ha tolto la maschera dell’inganno dal suo volto orribile, per rivelare l’ostilità radicata verso il popolo saharawi”. La posizione francese, secondo Omar, “esclude completamente la Francia da tutto ciò che ha a che fare con gli sforzi internazionali relativi alla decolonizzazione del Sahara Occidentale, inclusa la sua partecipazione alla MINURSO”.
L’Eredità Immortale: La Resistenza Come Identità di un Popolo
Oggi, mentre scrivo nel 2025, la situazione rimane in un perpetuo stato di conflitto a bassa intensità. La nomina di Staffan de Mistura come Inviato personale del Segretario generale delle Nazioni Unite per il Sahara Occidentale nell’ottobre 2021 ha portato una speranza limitata. La Corte dell’Unione Europea ha bocciato il 4 ottobre 2022 gli accordi tra il Marocco e l’UE relativi ai prodotti agricoli e alla pesca nel Sahara Occidentale, riconoscendo che giuridicamente il territorio non appartiene al Marocco.
Un punto di svolta giuridico importante è stato il caso Front Polisario contro il Consiglio dell’Unione Europea, in cui la Corte Europea di Giustizia ha riconosciuto implicitamente la personalità giuridica internazionale del Front Polisario come movimento di liberazione nazionale rappresentante del popolo saharawi. Come sottolinea l’analisi accademica di Eva Kassoti, “il Polisario è considerato un partecipante essenziale nel processo guidato dall’ONU per determinare lo status del Sahara Occidentale a causa del suo status di movimento di liberazione nazionale che rappresenta il popolo del Sahara Occidentale nella sua lotta per l’autodeterminazione”.
Ma i saharawi continuano a resistere con la stessa determinazione dei loro antenati che affrontarono le prime guarnigioni spagnole nel 1884. Come disse Malainin Lakhal: “L’assenza di scontri dagli anni ’90 ad oggi per noi non significa pace, ma repressione”. La loro lotta per l’autodeterminazione continua, sostenuta dalla solidarietà internazionale, come dimostrato dal Solidarity Rising Summit del gennaio 2025 nei campi profughi di Boujdour.
Secondo la documentazione araba sulla resistenza saharawi, il Fronte Polisario si definisce come “movimento di liberazione nazionale, frutto di una lunga resistenza saharawi contro varie forme di occupazione straniera”. I suoi principi fondamentali includono la “sacralità del popolo”, l'”unità nazionale”, la “lotta per l’indipendenza nazionale”, l'”unità territoriale” e la “salvaguardia dei valori del popolo saharawi e la protezione degli elementi della sua personalità nazionale”.
Il popolo saharawi rimane diviso tra chi vive sotto l’occupazione marocchina, chi nei campi profughi di Tindouf e chi sparso per il mondo in esilio. Ma tutti restano uniti dalla memoria, dalla lingua hassaniya, dalle tradizioni e dalla determinazione incrollabile a ottenere giustizia. Come dice il poeta Bahia Mahmud Awah: “Il mio verso è il tuo verso che sogna libertà, è il tuo verso che sogna amore, è il tuo verso che sogna pace”.
La poeta Salka Embarek scrive: “Soy el Sahara” (Io sono il Sahara), e in questo verso si condensa tutta la resistenza di un popolo che non ha mai smesso di credere. I saharawi sono il Sahara, e il Sahara è i saharawi. Non si può separare un popolo dalla sua terra senza uccidere entrambi. Da oltre 140 anni, dalla prima nave spagnola arrivata sulle loro coste nel 1884, i saharawi hanno dimostrato che l’oppressione può piegare i corpi, ma non può spezzare lo spirito di chi è nato libero nel deserto.
Il Sahara Occidentale rimane l’ultima colonia dell’Africa, ma i saharawi non hanno mai smesso di credere che un giorno torneranno alla loro terra come popolo sovrano. Questa è la loro storia, raccontata attraverso 141 anni di lotta ininterrotta, perché il mondo sappia che esistono, che resistono, e che non si arrenderanno mai. Come echeggia nei campi profughi di Tindouf e nelle città occupate del Sahara: “Sahara li’l-saharawiyin” – il Sahara appartiene ai saharawi.