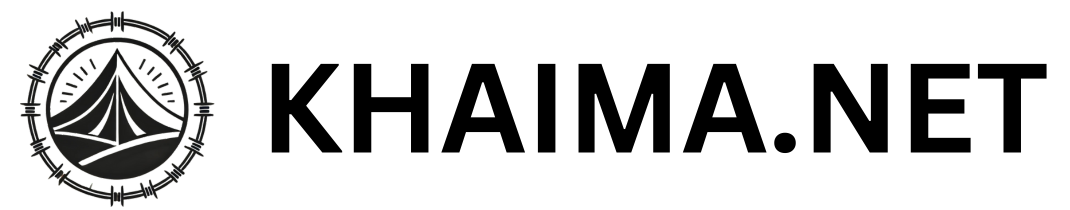La fabbrica del fango. Come il Marocco ha trasformato la diffamazione in un’industria

Era il 3 maggio, Giornata Mondiale della Libertà di Stampa, quando l’organizzazione marocchina “Hmm” pubblicò il suo ultimo rapporto: un documento freddo ma spietato, che parlava di un’impennata di campagne diffamatorie contro giornalisti indipendenti, oppositori politici e semplici attivisti della società civile.
Ma questa storia, in realtà, era cominciata molto prima.
Negli anni successivi al 2011, sull’onda del movimento del 20 febbraio, le speranze di un giornalismo libero in Marocco sembravano farsi strada. Giovani reporter, blogger e analisti politici iniziavano a usare i social media e le piattaforme indipendenti per denunciare corruzione, repressione e clientelismo. Eppure, quelle voci cominciarono presto a essere spente, una dopo l’altra, non con fucili o prigioni segrete, ma con articoli velenosi e video orchestrati da agenzie mediatiche vicine al regime.
Il nome più ricorrente nei salotti critici era uno: “abuaq al-makhzen”, le testate filo-governative che agivano come vere e proprie truppe della propaganda. E tra queste, alcune divennero simbolo di una trasformazione inquietante: il passaggio dalla cronaca alla calunnia sistematica.
Nel 2020, il giornalista Hamid El Mahdaoui fu arrestato e condannato a tre anni di carcere per non aver denunciato un presunto piano di rivolta armata – una notizia mai verificata, che si rivelò poi inconsistene. Il suo vero crimine? Aver dato voce ai movimenti sociali del Rif e criticato apertamente la corruzione che dilaniava le istituzioni.
Due anni prima, nel 2018, un altro nome prese fuoco nelle redazioni indipendenti: Omar Radi, giornalista investigativo noto per aver svelato accordi fondiari truccati e leggi approvate in cambio di tangenti. Radi fu inizialmente perseguito per un tweet contro un giudice. Poi, nel 2020, fu arrestato con accuse gravi e vaghe: spionaggio e violenza sessuale. Organizzazioni internazionali come Amnesty International denunciarono l’assurdità delle accuse. Ma la macchina era già in moto.
Oggi Omar Radi e Hamid El Mahdaoui sono formalmente liberi, ma la loro libertà è solo apparente. Le ferite della prigione, le campagne diffamatorie e i processi farsa hanno lasciato cicatrici profonde. Nonostante siano usciti dalle celle, continuano a vivere da prigionieri di un sistema assurdo che non smette di perseguitarli. La macchina della diffamazione non ha mai smesso di colpirli, alimentando sospetti, isolamento e intimidazioni. I loro nomi, una volta simbolo di coraggio giornalistico, restano sotto assedio, come se la verità che hanno cercato di raccontare fosse un crimine imperdonabile.
Come raccontò la giornalista Fatima El Afriqi, la diffamazione non era più un’eccezione. Era diventata un mestiere. In un articolo dal titolo provocatorio “Il mestiere: diffamatore”, scrisse con amara ironia:
“Nel Marocco di oggi, la diffamazione non è più un errore isolato. È un lavoro organizzato, con tesserini, ‘star’ di prima e seconda categoria, protettori e squadre digitali di mosche pronte a pungere chiunque osi alzare la voce”.
Era il 2023 quando El Afriqi lanciò una proposta provocatoria: fondare l’Agenzia Nazionale per la Diffamazione, e creare persino un premio ufficiale – una statuetta a forma di pistola – da assegnare al “miglior articolo killer”.
I bersagli erano noti: chiunque osasse indagare sui soldi che giravano dietro certe leggi, sui giudici corrotti, sugli affari torbidi tra funzionari e imprenditori legati al potere. Nessuno era al sicuro, nemmeno i giornalisti che non si schieravano apertamente contro il regime ma che, semplicemente, cercavano di raccontare la verità.
Molti venivano accerchiati da campagne orchestrate: foto private pubblicate, falsi scoop, accuse personali. Altri subivano assedii giudiziari: convocazioni infinite, divieti di viaggiare, pignoramenti. Le loro famiglie venivano minacciate, i loro figli insultati online.
La giornalista concludeva così, tracciando un parallelo con i tempi più oscuri della storia:
“Una volta si giustiziavano gli oppositori con il fuoco e la decapitazione. Oggi basta un articolo menzognero, un video manipolato o una diretta infame per distruggere la reputazione di un uomo e seppellirlo vivo nell’indifferenza digitale”.
Oggi, nel 2025, la situazione non è cambiata. Anzi, la macchina del fango si è affinata, digitalizzata, moltiplicata.
Ma nonostante tutto, c’è ancora chi scrive, chi denuncia, chi racconta. E mentre le diffamazioni si moltiplicano, cresce anche il numero di lettori che capisce. Che non si lascia ingannare. Che comincia a chiedersi: “Chi sono davvero i criminali?”